
Delega:
il superpotere che non trovi nei fumetti
La delega è quel concetto di cui tutti abusano, ma che, allo stesso tempo, temono di più.
È una rappresentazione potente, capace di scremare i sostenitori di facciata da chi, invece, è davvero disposto a credere nel suo valore intrinseco.
In azienda se ne parla apparentemente con convinzione : la si cita come leva strategica, la si raccomanda nei piani di sviluppo, si ripete che è la chiave per far crescere le persone.
Tutti si trovano d’accordo sulla sua imprescindibilità. Poi, arriva il momento di passare alla pratica e, improvvisamente, si è troppo impegnati per poter affrontare l’argomento: si rimanda, si riprogramma, si prende tempo.
Perché, in fondo, diciamocelo onestamente, affidarsi a qualcuno senza avere il controllo , è come buttarsi da un aereo con il dubbio che il paracadute possa non aprirsi: non tutti sono disposti a correre il rischio.
E quando la paura di non avere più il polso della situazione prende il sopravvento, sovrastando ogni altra considerazione, si rischia di compromettere tutto il processo di delega, incorrendo in errori comportamentali che, invece di favorire il coinvolgimento e il senso di appartenenza, minano profondamente la fiducia del singolo o dell’intero team.
Attenzione ai falsi deleganti
C’è chi si lascia offuscare dalla sindrome del “Ti lascio fare, ma a modo mio”, dove la delega è solo un atto formale: tutto è già stato deciso e predisposto a monte. Le direttive – impartite sotto mentite spoglie – devono essere seguite alla lettera; c’è chi si è costruito intorno a sé un muro di diffidenza : si convince del fatto che i membri del proprio team non siano sufficientemente preparati, basandosi sull’errata credenza che le delusioni del passato con vecchi collaboratori si riproporranno con feroce certezza anche in futuro. Non è disposto a cedere alcun compito, anche se questo dovesse saturare completamente il suo tempo con attività secondarie; c’è chi interpreta la delega come un totale trasferimento della responsabilità, liberandosi da ogni onere di supporto e supervisione, salvo poi essere pronto, con lucida freddezza, ad attribuire colpe o ad assumersi meriti, a seconda dell’esito del progetto; c’è chi finge di concedere autonomia ai propri collaboratori, ma non li lascia mai a briglie sciolte, soffocandoli con continue richieste di aggiornamenti. Inoltre, al primo piccolo intoppo, rientra in campo a gamba tesa per riprendersi tutte le attività demandate; c’è chi non riesce a essere chiaro nella comunicazione, sia nell’assegnazione dei compiti che nella restituzione dei feedback; infine, c’è il tipo peggiore di manager: quello che, avendo intuito le potenzialità dei propri collaboratori, sceglie consapevolmente di non farli crescere, né d’investire sulle loro abilità, assegnando soltanto compiti di poco conto. Ciò, per timore di risultare inadeguato vicino a loro, poiché possono mettere in ombra la sua posizione di potere.
Perché vale la pena credere nella delega
Eppure la delega, se usata con sapienza, può diventare una delle soft skill più determinanti nelle mani di un manager, in grado di generare benefici su più livelli:
personale → alleggerisce il carico di lavoro, permettendo al manager di focalizzarsi su obiettivi strategici e a lungo termine; libera spazio mentale per supervisionare, affiancare e far crescere i collaboratori; aumenta la consapevolezza sulle competenze già presenti nel team e su quelle ancora da sviluppare; consolida la sua reputazione, non solo agli occhi del proprio gruppo, ma anche presso gli altri reparti. Un manager che sa delegare bene non resta solo nella memoria: resta nel cuore;
di gruppo → la delega ben calibrata fa crescere le persone, affidando compiti stimolanti che le fanno sentire parte integrante del processo di miglioramento (potete approfondire l’argomento nell'articolo il ciclo perfetto); alimenta il senso di appartenenza e la motivazione, perché chi riceve fiducia tende a ricambiarla con il massimo impegno; apre la porta a nuove prospettive e soluzioni creative, lasciando libertà di proporre strade alternative per raggiungere lo scopo, pur restando all’interno di un metodo condiviso;
organizzativo → accelera il flusso decisionale, rendendo le procedure più flessibili e capaci di adattarsi alle esigenze del momento; rafforza la collaborazione tra reparti, perché le persone sono costrette a parlarsi per portare a termine un obiettivo comune; abbatte il muro dell’irraggiungibilità tra manager e collaboratori, trasformando la comunicazione verticale in un dialogo più autentico e costruttivo.
Investire, anche sbagliando
Si può quindi dedurre che la delega sia un vero e proprio investimento in cui vale davvero la pena credere, poiché i vantaggi ottenuti superano di gran lunga i costi derivanti da qualche scelta non ottimale.
A patto, naturalmente, di saperla gestire con metodo: ed è qui che entrano in gioco alcuni modelli molto interessanti, capaci di guidare i manager verso scelte più oculate. Gli accademici Reginald L. Bell e Nancy Dusty Bodie, per esempio, partendo dal processo di delega elaborato da Dunham e Pierce — articolato in quattro fasi (assegnazione dei doveri, trasferimento dell’autorità sui compiti, definizione delle condizioni di approvazione e creazione della responsabilità) — propongono una riconfigurazione aggiornata.
Questa evoluzione si fonda, tra gli altri, sul paradigma secondo cui il cuore della pratica manageriale non è solo assegnare compiti, ma garantire che autorità e responsabilità siano delegate in misura proporzionale: una logica che si traduce in un processo ancora più strutturato e bilanciato, come vedremo tra poco.
Le quattro fasi per delegare con metodo
Prima fase – capire quale tipo di autorità possa essere trasferita: i manager, per posizione e per loro natura, dispongono di due tipi di autorità sovrapponibili: quella formale, derivante dal titolo ufficiale e dalla posizione gerarchica ricoperta; quella informale, acquisita attraverso la propria reputazione e riconosciuta dagli altri come legittima, che gli conferisce l’influenza necessaria per dare ordini – che verranno ascoltati – a prescindere dalle formalità. Quest’ultima, per ovvi motivi, non può essere ceduta.
Seconda fase – definire i task e trovare la persona più adatta per l’assegnazione: questa è una fase cruciale, poiché può decretare il successo o il fallimento dell’intero progetto. Per prima cosa, il manager deve definire i task con la massima specificità possibile: maggiori sono gli input di cui il delegato dispone, migliori sono le possibilità che quest’ultimo li possa portare a termine con esito positivo. È quindi fondamentale comunicare cosa si voglia ottenere, perché questi compiti siano stati commissionati, quale sia il loro valore in termini di output, quali risorse di partenza siano state definite e in quali tempistiche si debbano completare. È altrettanto importante, poi, scegliere con cura il canale e la modalità di comunicazione (briefing individuale, riunione, documento scritto), così da garantire chiarezza e reperibilità immediata delle informazioni. A questo punto, occorre valutare con attenzione chi sia la persona più adatta: non solo in base alle competenze tecniche, ma anche considerando l’esperienza pregressa, la disponibilità di tempo, la motivazione e la capacità di lavorare in autonomia. Stilare una lista delle competenze e delle capacità necessarie può rivelarsi funzionale: una scelta ben ponderata riduce il rischio di incomprensioni e aumenta la probabilità di ottenere risultati di qualità.
Terza fase – consentire alla persona di accettare o rifiutare le condizioni d’incarico: dopo aver parlato con la persona, spiegando le ragioni della scelta e lasciando spazio a domande e chiarimenti (confronto prezioso per individuare punti critici e apportare delle modifiche prima dell’avvio, evitando così fraintendimenti), il potenziale delegato deve poter accettare o rifiutare l’incarico, motivando la propria decisione. In caso di diniego, si ritorna alla prima fase: rivedere il processo alla luce delle nuove informazioni può facilitare la scelta successiva; in caso di consenso, invece, si valutano insieme le abilità di tutte le risorse coinvolte, procedendo, in caso di necessità, all’addestramento necessario per poter eseguire i task. In questa fase, è anche opportuno concordare il sistema di feedback e reportistica, così da garantire al delegato la piena autonomia senza rinunciare a un flusso informativo costante.
Quarta fase – trasferire l’autorità formale, creare la responsabilità e permettere l’autonomia operativa: è il momento in cui avviene il trasferimento formale, da parte del manager, dell’autorità e della responsabilità al delegato, con una sua minima supervisione. Questo non significa sparire dai radar: conferire la responsabilità dei task non comporta la rinuncia alla propria (ne parliamo nell'articolo sulla responsabilità). Il manager resta a disposizione per supporto e comunicazione, seguendo le modalità concordate e verificando i progressi nei momenti stabiliti.
Quando il talento è acerbo, ma le opportunità immense
E se, invece, il manager punta su qualcuno dal potenziale enorme ma con abilità ancora acerbe? In questi casi, la procedura di delega diventa anche un momento di sperimentazione calibrata, con un approccio più graduale.
In un primo periodo è utile proporre task con soluzioni multiple — alcune efficaci, altre meno — così da circoscrivere eventuali errori e monitorare il processo decisionale del delegato.
Questo “campo di prova” serve a comprendere se il candidato tende a convergere verso le opzioni più valide o se è addirittura in grado di proporne di migliorative. In un secondo periodo, il manager può aggiustare il tiro: aumentare gradualmente la complessità, incrementando l’autonomia, oppure fornire supporto più mirato in base alla performance osservata.
È vero che questo richiede un investimento iniziale in supervisione, ma il ritorno, in termini di sviluppo, fiducia e comprensione del talento, può essere decisivo per accelerare lo sviluppo delle competenze.
Conclusioni
Chiudendo il cerchio, la delega non è mai un atto passivo. È un esercizio di previsione, di fiducia e di verifica mirata, dove ogni fase – dalla definizione del compito alla scelta della persona – incide in modo diretto sul risultato finale. Non è un processo statico: richiede aggiustamenti, scelte consapevoli e, talvolta, qualche rischio calcolato. Ma quando è ben strutturata, la delega non solo libera risorse chiave, ma fa crescere le persone coinvolte e, con loro, l’intera organizzazione.
Se non l’hai ancora fatto, il momento migliore per iniziare a delegare in modo strategico è oggi: “lo faccio io che faccio prima” non è una tattica efficace sul lungo periodo.
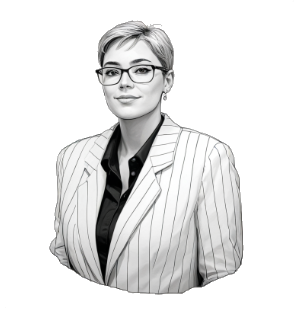
Autrice
Elena Vecchiolini
Chi sono (in breve)
Mi occupo di consulenza aziendale con una spiccata passione per le persone, la gestione aziendale e la digitalizzazione.
Scrivo articoli per Kaizendo mescolando esperienza, curiosità e una sana dose di ironia. I miei temi preferiti?
Li conoscete già: HR, soft skill, strategie organizzative e tutto ciò che aiuta logica e creatività a convivere nelle scelte aziendali.
Credo nel potere delle domande (ne faccio molte), nell'istinto supportato dalla logica e nello sperimentare soluzioni che non sembrano soluzioni… finché non funzionano.
Motto personale? Non esiste un piano ben congeniato: devi saper seguire la corrente per capire come arrivare al mare.

