
I bisogni umani dal panino al burnout:
Boomer sazi, Millennial in cerca, Gen Z in analisi
Discipline come economia, psicologia e affini riescono a convivere pacificamente pur sostenendo teorie opposte. Come se un vegano e un allevatore di bovini riuscissero a cenare insieme con autentico piacere.
Le cose peggiorano quando entriamo nel regno delle teorie sui bisogni umani: è come frugare nel frigo e buttare tutto in una zuppa “creativa”. Il risultato? Una base accettabile per tutti (le patate stanno bene ovunque), ma con qualche broccolo filosofico indigesto che rovina il tutto.
Maslow: il muratore dell’anima
Partiamo da Abraham Maslow, psicologo novecentesco convinto che i bisogni potessero essere organizzati come i livelli di un videogioco.
Li mise in fila in quella che tutti conosciamo come la sua famosa piramide: si parte dai bisogni fisiologici — fame, sete, sonno — che, diciamocelo, rendono irrilevante ogni ambizione da CEO quando stai morendo di fame. Si sale poi al bisogno di sicurezza: un lavoro stabile, un tetto sopra la testa, magari anche un’assicurazione sanitaria o almeno una copertura infortuni dignitosa. Poi viene il bisogno di appartenenza, che oggi include amici, affetti e — perché no — anche qualche like sui social. Il gradino successivo è la stima: sentirsi rispettati dagli altri e da sé stessi, un po’ come un buon post su LinkedIn che fa il pieno di applausi digitali e commenti. Infine, in cima, c'è l’autorealizzazione: diventare ciò che si può essere, magari aprendo una startup di intelligenza artificiale poetica che nessuno capisce ma che ti rappresenta profondamente.
L’idea di Maslow era chiara: una volta soddisfatti i bisogni di base, si passa a quelli superiori.
Alderfer e la teoria dell’ascensore emotivo
Nel 1969 arriva Clayton Alderfer che, guardando la piramide, esclama: “Bella, ma la gente non sale: rimbalza.” Ecco allora la sua versione: il modello ERG, che riassume Maslow in tre categorie.
C'è l’Existence, cioè tutto ciò che riguarda sopravvivenza e sicurezza — soldi, salute, stabilità. Poi la Relatedness, che include le relazioni umane, gli affetti, il bisogno di sentirsi parte di qualcosa. Infine la Growth, ovvero lo sviluppo personale, la voglia di imparare, evolversi, dare un senso al proprio percorso.
Il punto è che in ERG non esiste una gerarchia rigida: i tre bisogni coesistono, si sovrappongono, si alternano. E se uno di questi viene frustrato, possiamo regredire verso un altro. Se non mi promuovono, magari cerco conforto nella socialità. Se vengo ignorato anche lì, mi chiudo in casa a ordinare sushi e a fare binge-watching su Netflix. Questo modello spiega molte dinamiche aziendali, dal “quiet quitting” al collega che ogni lunedì cambia obiettivo di vita (e tool di produttività).
La Gen Z rompe tutto, di nuovo
Tutto questo torna... finché non arriva la Gen Z. Quelli che non vogliono fare carriera, ma nemmeno vivere in povertà. Che rifiutano il contratto a tempo indeterminato se toglie loro autonomia. Che hanno vissuto una pandemia, osservano il mondo bruciare e non si fidano troppo dei piani a lungo termine.
E così, mentre Maslow e Alderfer iniziano a sudare freddo, entrano in scena Deci & Ryan con la Self-Determination Theory (SDT).
La loro intuizione è semplice e potente: le persone fanno le cose perché vogliono farle, non solo perché devono.
I tre bisogni fondamentali della SDT sono l’autonomia — il desiderio di scegliere come agire e non essere meri esecutori —, la competenza — la voglia di sentirsi capaci e di saper fare bene ciò che si fa —, e la relazione — il bisogno di sentirsi parte di un contesto significativo.
Così, se lasci un lavoro sicuro per aprire un negozio di piante, magari lo fai perché scegli un ambiente che ti ispira (autonomia), con persone che ti supportano (relazione), e in cui impari cose nuove che ti fanno sentire vivo (competenza). Non è fuga: è espressione di sé.
Il modello giusto non esiste
I modelli sono mappe, non il territorio. Sono utili, certo, ma parziali. Servono per osservare e analizzare la realtà, ma non la sostituiscono. Possiamo usarli per comprendere clienti, dipendenti, amici, ma dobbiamo sempre ricordare che l’essere umano è una variabile impazzita in un’equazione infinita.
Le generazioni, ad esempio, mostrano pattern differenti: un baby boomer tende a cercare stabilità e rispetto per l’esperienza, quindi si muove tra bisogni di esistenza e relazione. Un millennial, invece, cerca significato e autonomia, collocandosi tra crescita e autodeterminazione. La Gen Z? Sta creando un modello a parte, che sembra ibridare SDT e disincanto post-capitalista.
Anche il ruolo in azienda influisce: un manager cerca fiducia, delega e prospettiva, mentre un executive è più orientato a influenza, visione strategica e impatto. Le variabili sono tante, in continua evoluzione.
E se il profilo lo scrivesse l’IA?
In tutto questo, mentre noi giochiamo con modelli e teorie, c’è un’altra intelligenza che ci osserva, ci ascolta, ci analizza. Le IA stanno imparando a riconoscere i nostri pattern, rispondere alle nostre domande e — forse — anticipare i nostri bisogni. Ogni prompt che lanciamo diventa una traccia del nostro modo di pensare. E senza accorgercene, ci stiamo facendo profilare. Ma a differenza dei vecchi schemi, questa volta il profilo non lo scriviamo noi.
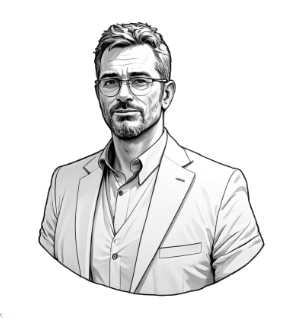
Autore
Enrico Parolin
Chi sono (in breve)
Mi occupo di consulenza strategica con un focus su digital transformation, organizzazione del lavoro e marketing.
In Kaizendo porto metodo, struttura e una certa ossessione per i dati che parlano (e per quelli che non parlano, ma dovrebbero).
Scrivo e progetto strumenti concreti per aiutare le aziende a prendere decisioni più consapevoli, ridurre gli sprechi informativi e trasformare la complessità in qualcosa di semplice, utile e operativo.
Credo nei modelli che funzionano davvero, nella ristrutturazione creativa dei processi e nell’efficacia delle soluzioni silenziose.
Motto personale? La chiarezza è rivoluzionaria.

